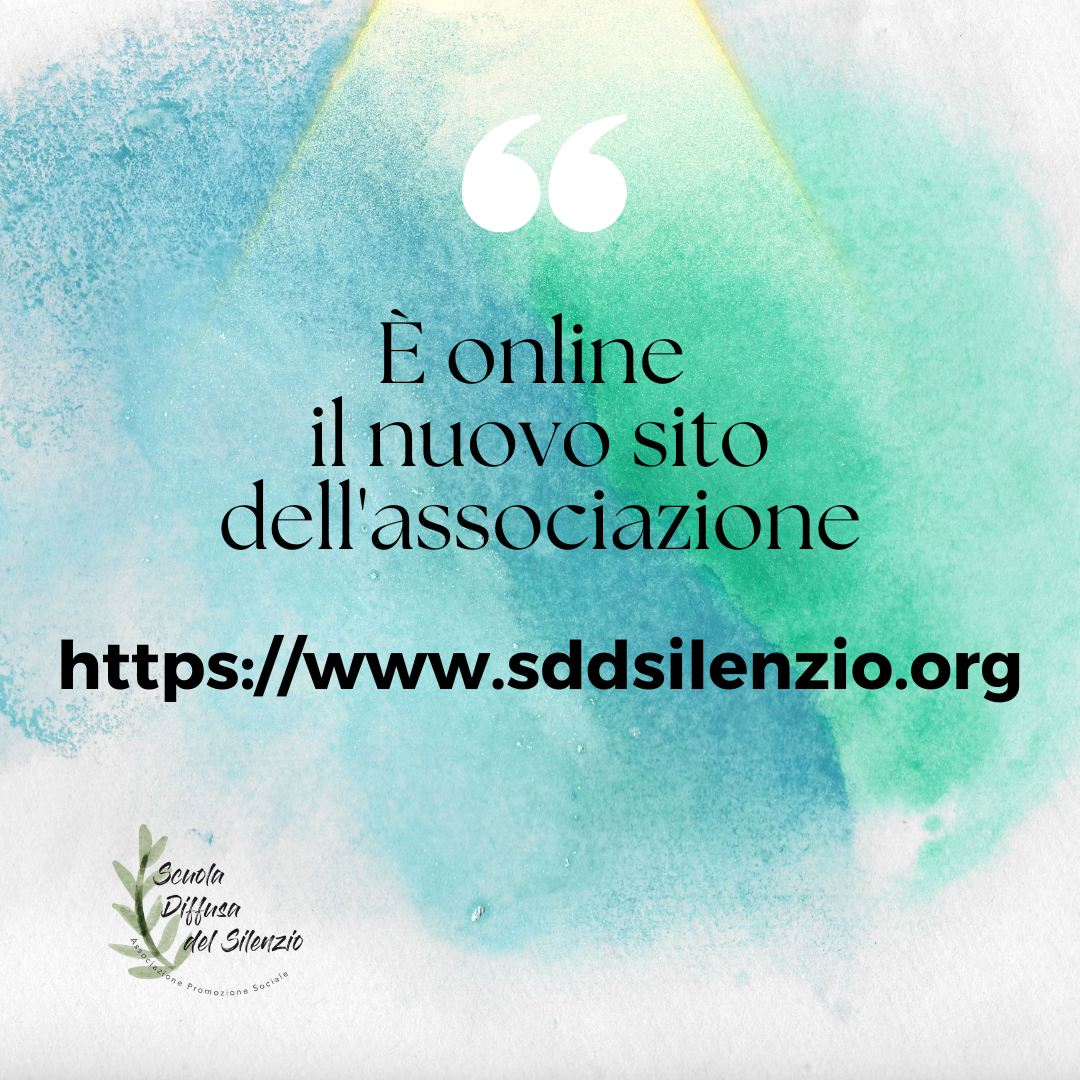Gv 3, 13-17
La croce è il segno radicale dell’umana avventura: accoglienza della finitezza senza vie di fuga, stare fino in fondo e dentro il limite senza avversione.
Punto d’incrocio dove si sfiorano gli opposti: terra e cielo, materia e spirito, tempo e infinito, solitudine e abbraccio. In questo centro pulsa tutta la condizione umana: sospesa tra il peso del finito e la vertigine dell’oltre.
Gesù sulla croce non è l’ultima vittima offerta a un dio crudele, ma l’uomo nella sua verità più nuda. Egli non evade dalla violenza, non risponde con l’odio, non si sottrae al dolore. Resta. Sta. Esposto, inerme, eppure sovrano.
In lui la sventura estrema diventa grandezza estrema, la ferita si apre come varco d’infinito. La croce si fa allora icona di dignità: non chi cede al male, ma chi lo attraversa s’apre a spazi inimmaginabili.
La croce è dunque sosta dentro il negativo. Non per amore del dolore, ma perché soltanto nel varcarlo può nascere l’oltre. Nel nulla più buio può trasparire il Tutto. Rivelando così quel Mistero che non è un dio tra gli dèi, ma la profondità stessa dell’essere, che si rivela quando crollano tutte le immagini e gli appigli.
La resurrezione, va da sé, non è magia proveniente dall’esterno, ma vita che risorge dal cuore stesso della perdita, forza che non si lascia seppellire, fiducia che nessuna morte potrà mai avere l’ultima parola.
In un tempo che fugge il dolore come scandalo, la croce resta segno ostinato. Ci dice che non c’è vita senza ferita, né amore senza esposizione, né relazione senza vulnerabilità. Ma dice anche che nessuna ferita è chiusura: ogni piaga nasconde un varco di luce.
Così la croce parla ancora oggi, oltre le religioni e oltre il teismo: come simbolo universale dell’umano, della capacità di trasfigurare il dolore in amore, la sconfitta in apertura, il limite in possibilità.