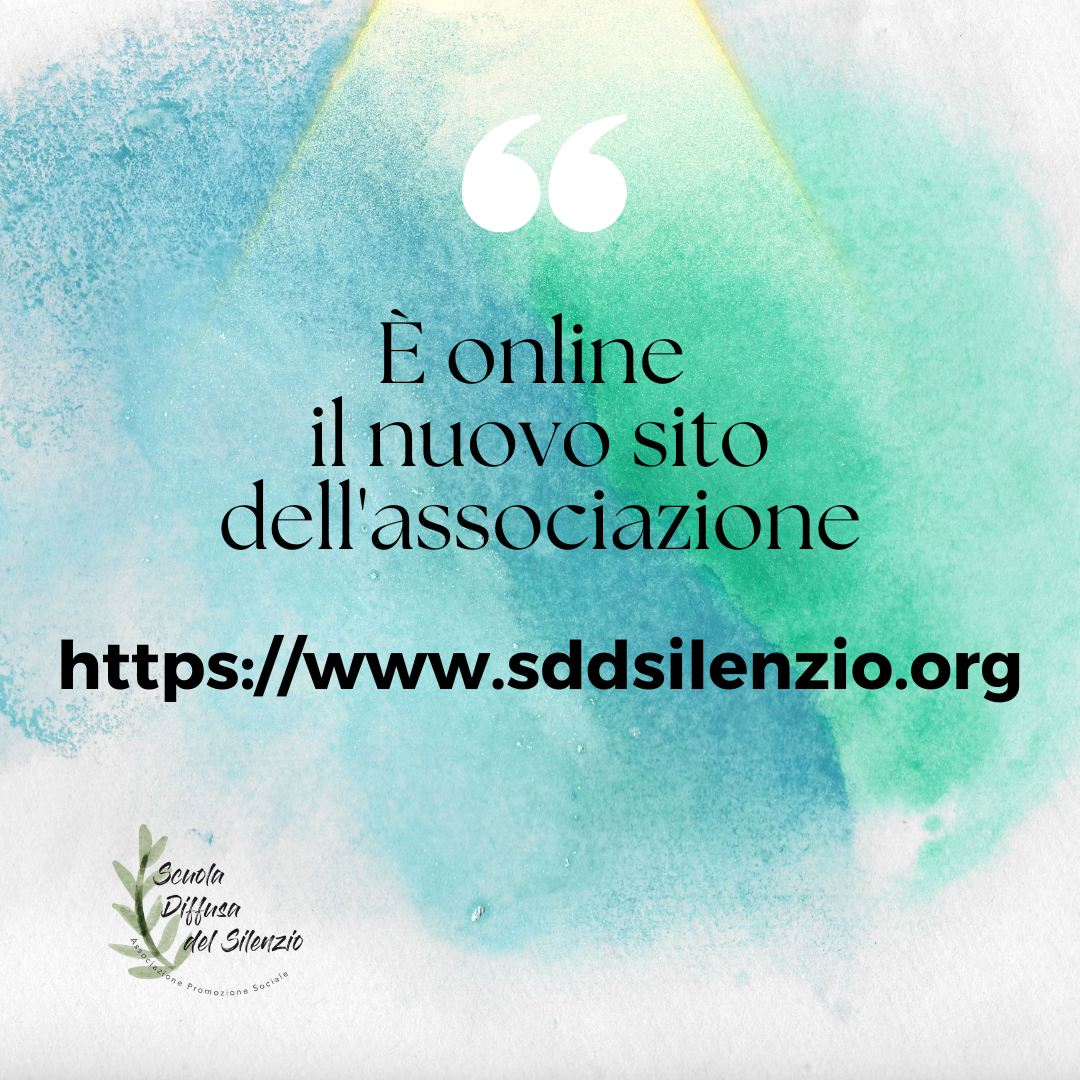Lc 18, 9-14
Tra il fariseo e il pubblicano non v’è una differenza morale, ma di coscienza. Uno è pieno di sé, l’altro è semplicemente aperto. Uno si giustifica, l’altro si lascia attraversare.
Il primo si è costruito un’identità religiosa per potersi salvare dal vuoto; l’altro, proprio nel vuoto, ritrova sé stesso.
Se la religione promette un legame con l’alto, la fede è piuttosto uno sprofondare in sé stessi. La fede non chiede di osservare, ma piuttosto di essere, e non pretende che si compiano opere per raggiungere il divino, ma vivere della presenza del divino in sé.
Paolo ricorda che «Siamo giustificati per la fede, non per le opere della Legge» (Gal 2,16): cioè, siamo resi interi non dal fare, ma dal lasciare accadere; perché alla fine ciò che salva non è lo sforzo, ma la resa. Non la prestazione, ma la trasparenza.
Il “divino” — parola forse logora, ma ancora necessaria — non è un Essere che abita altrove. È la vita stessa che, quando smettiamo di afferrarla, ci abita. È ciò che resta quando crollano le difese dell’io. La Presenza senza nome che riempie l’assenza.
Il fariseo della parabola è un uomo che giudica, perché non ha mai guardato davvero sé stesso. Chi invece si riconosce fragile non potrà più escludere nessuno; infatti, la verità di sé è la fine di ogni giudizio.
Quando Dostoevskij fa dire al Cristo: “Venite anche voi, o ubriaconi, o dissoluti… se li accolgo è perché non si sono mai creduti degni” (Delitto e castigo), sta dicendo che solo chi ha toccato il fondo dell’umano può comprendere l’interezza della vita.
La vera giustizia non è morale ma ontologica: consiste nel non separare più. Nel sentire che tutto ciò che esiste — anche il nostro errore, la nostra notte — è già accolto dentro un respiro più grande.
Quando questo accade, non c’è più un Dio che salva, ma un silenzio che comprende. Non un cielo che premia, ma un cuore che finalmente si apre e tace.